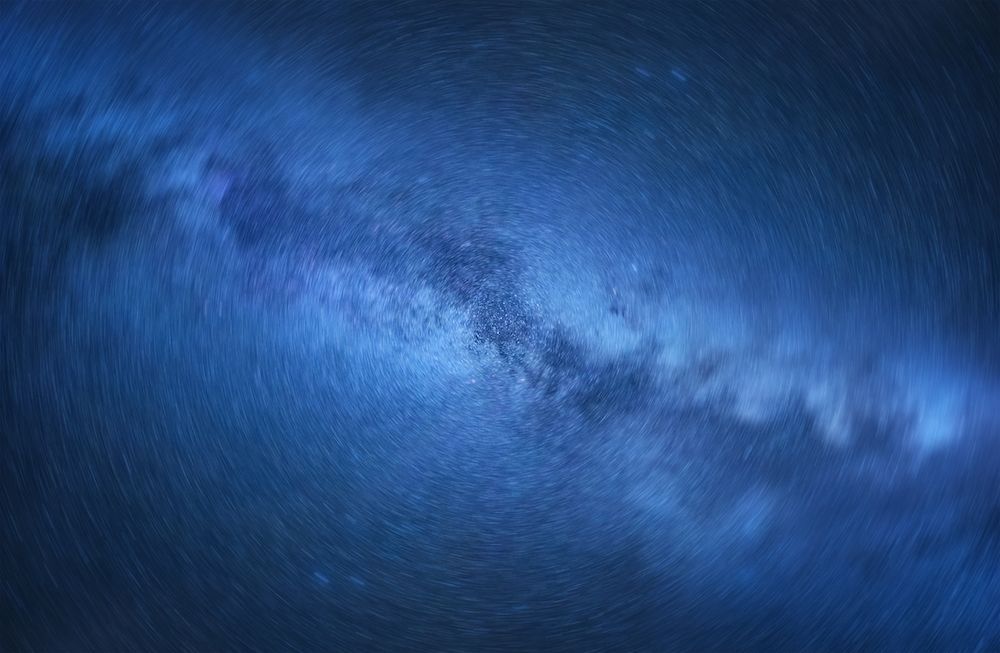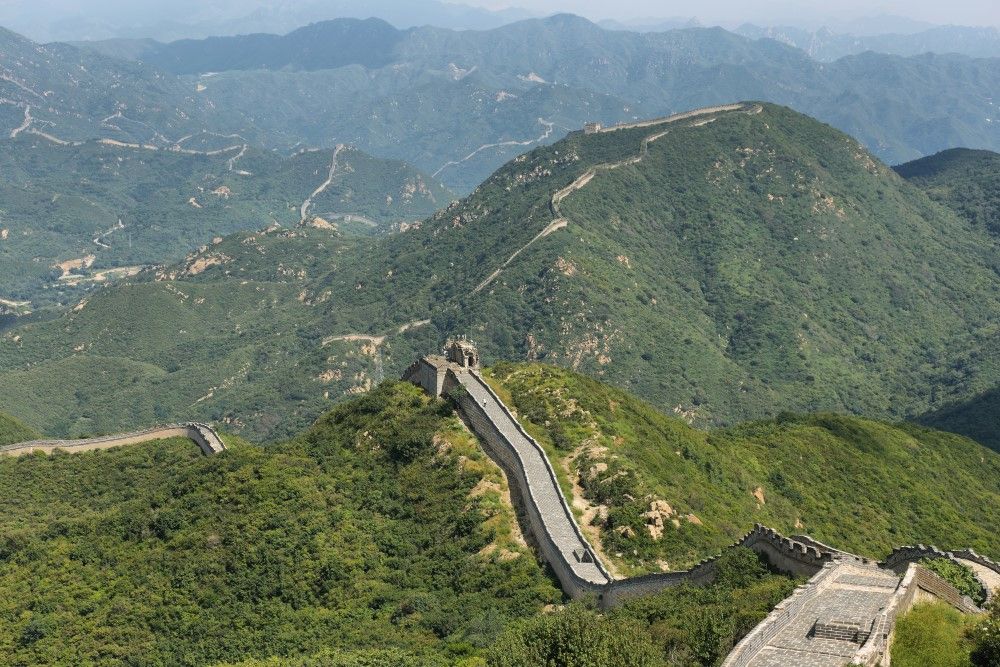Nel 1902 una spedizione archeologia francese scoprì tra le rovine dell’acropoli di Susa, ex capitale dell’Impero Persiano, uno dei più preziosi documenti legislativi della storia: il codice di Hammurabi. Oggi rappresenta uno dei gioielli della collezione di antichità orientali del Museo del Louvre, a Parigi, ma se ne può ammirare una copia anche al Pergamon museum, a Berlino.
Il codice
Prende il nome da Hammurabi, sesto re del primo Impero Babilonese, che governò dal 1792 a.C. circa al 1750 a.C circa. Si tratta forse del primo esempio di leggi esposte alla libera consultazione dei cittadini (per lo meno quelli che sapevano leggere): nella parte superiore è raffigurato lo stesso Hammurabi, in piedi al cospetto del dio Marduk, il sovrano celeste di Babilonia, che gli porge il cerchio e il bastone, simboli tradizionali del potere regale.
Al di sotto si trovano invece delle iscrizioni cuneiformi, suddivise in 51 colonne, con un prologo che occupa tutta la parte superiore delle scritture. Qui il re celebra la propria potenza e la propria autorità, affermando che il suo potere è legittimo e giusto poiché difende il diritto.
A seguire, si possono vedere i 282 articoli del codice, riguardanti la proprietà, la famiglia, la successione, le offese fisiche, gli affitti, i salari, gli schiavi, gli animali e … la birra!
Il “taglione” della birra
Il principio fondamentale di tutto il Codice è la cosiddetta “legge del taglione”, che potrebbe essere tradotta in: “occhio per occhio, dente per dente”. Com’è possibile applicare un tale principio, se si parla di birra?
Presso i Babilonesi la bevanda rappresentava una merce di scambio. Il codice di Hammurabi stabiliva che ogni cittadino doveva avere una razione di birra garantita, distribuita in base allo status sociale. Un manovale, per esempio, riceveva 2 litri al giorno, mentre i dipendenti pubblici 3 e gli amministratori e gli alti sacerdoti 5 litri al giorno.
Gli articoli 108, 109, 110 e 111 sono dedicati ai “reati della birra”:
108: Se una taverniera non accetta frumento secondo il peso lordo per il pagamento della birra, ma prende denaro, o se ricevendo il frumento, annacqua la birra, sia condannata e gettata nell’acqua.
La birra, sostanzialmente, doveva essere venduta al medesimo prezzo dell’orzo, chi applicava un sovrapprezzo, doveva essere annegato.
109: Qualora cospiratori s’incontrino nella casa di una taverniera tenutaria di taverna, e questi cospiratori non sono catturati e consegnati alla corte, la taverniera tenutaria di taverna sia messa a morte.
Questo articolo non necessita di ulteriori spiegazioni.
110: Qualora una sacerdotessa apra una taverna, o entri in una taverna per bere, questa donna sia arsa viva.
Quando una donna decideva di diventare sacerdotessa, il suo percorso era assimilato a un matrimonio con il dio o la dea del tempio, infatti questa scelta poteva essere presa solo in età adulta. Le sacerdotesse potevano sposarsi, avere degli schiavi a disposizione, conducevano uffici religiosi ma, a quanto pare, dovevano rimanere astemie.
111: Qualora una tenutaria di locanda serva a credito 60 Ka (unità di misura non conosciuta) di birra, ella riceva 50 ka di frumento al tempo del raccolto
Difficile dare una precisa interpretazione dell’ultimo articolo, si capisce però che la birra rappresentava un bene comune prezioso, tanto che il governo si impegnava a consegnare dei prodotti, per garantire una continuativa produzione di birra.
Chissà se a Babilonia conoscevano le tecniche della spillatura perfetta: rivediamole!